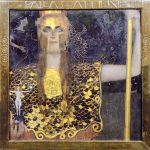Emanuele Gallotta ci ha guidato in un percorso di circa sei chilometri all’interno dei circa centocinquanta ettari dell’area di Portus, illustrandocene tutte le fasi, dall’originario porto fluviale ai due porti imperiali di Claudio e di Traiano, con una capacità notevole di rappresentarci quello che non si vede più, facendoci immaginare l’acqua dove ora c’è un percorso sterrato in mezzo a un magnifico bosco di lecci, querce, allori e tamerici e, intorno a quest’acqua, le strutture portuali, l’isola, il faro.
Dunque anzitutto porto fluviale destinato a navi di piccolo cabotaggio e a fondo piatto (le caudicarie) poi, per volontà di Claudio, a partire dal 42, grande porto marittimo per Roma. L’Urbe infatti contava ormai un milione di abitanti e il suo porto marittimo, quello che poteva ospitare e far salpare le merci che arrivavano o partivano da Roma, si trovava a Pozzuoli, a una distanza che rendeva gli approvvigionamenti e i commerci lenti e difficili. Nonostante pareri tecnici sfavorevoli per il rischio di insabbiamento, Claudio iniziò l’impresa poi terminata da Nerone.
Il porto, come previsto, si insabbiò per i detriti che scendevano dal fiume e anche per la sabbia che entrava dal mare in seguito alle mareggiate, accumulandosi nel bacino che aveva due larghi moli e al centro l’isolotto con il faro.
Le vestigia del porto sono comunque ingenti e impressionanti: i magazzini detti traianei ma già esistenti nell’età di Claudio, si articolavano su tre piani ed erano costruiti con la consueta maestria. I muri in opera cementizia, con “caementa”, calce e molta pozzolana per migliorare la carbonatazione e dunque la coesione in ambiente umido e marino, avevano uno spessore di un metro per garantire l’isolamento e una ottimale conservazione delle merci (principalmente grano dall’Egitto), scaricate dalle grandi navi onerarie, poi trasportate con il sistema di alaggio, risalendo il fiume, in città. Il paramento esterno aveva i mattoni a facciavista. L’interno era invece intonacato e sotto il pavimento si vedono ancora le suspensurae, sorta di vespaio per bloccare l’umidità.
I locali erano tutti coperti con volte a botte, cosa che rendeva il sistema molto robusto, essendo molti locali attaccati l’uno all’altro.
Ma il luogo più evocativo è senza dubbio la via colonnata del Portico di Claudio. Quelle colonne lasciate sbozzate per scelta, con intenzione estetica di fissare lo stato in fieri dell’opera, (come nel Claudianum, a Porta Maggiore, ecc.) sono per noi di un fascino particolare. Perché ci parlano della ripresa che del rustico, dell’abbozzato, si fece nel Rinascimento e – soprattutto – nel barocco berniniano.
L’insabbiamento progressivo portò a un uso ridotto e meno sicuro del porto, tanto da indurre Traiano, tra il 100 e il 112 dopo Cristo, alla costruzione di un nuovo bacino esagonale, non visitabile perché proprietà privata non espropriabile: lo si può ammirare da lontano, da un belvedere purtroppo non accessibile a persone con disabilità, dietro la recinzione metallica che separa i due siti. La forma esagonale era la più adatta sia a spezzare il moto ondoso (che un bacino circolare non avrebbe neutralizzato) sia ed evitare parti non utilizzabili, cosa che sarebbe avvenuta con un bacino quadrato con angoli di 90°. Ogni lato è lungo 360 metri e il bacino, che era profondo 8 metri, poteva contenere oltre cento navi onerarie. Decisamente una svolta…
Nonostante il fatto che tra II e III secolo l’accresciuta importanza del luogo portasse a un conseguente maggior numero di abitanti e, nel IV, alla denominazione ufficiale di città con il nome di Portus Romae, il lento impaludamento, le invasioni barbariche determinarono, già nel V secolo, un progressivo spopolamento.
Il sito fu infine abbandonato durante il 1300 e solo nel 1800, su sollecitazione dei Torlonia che ne divennero proprietari, si iniziò a scavare per trovare reperti e a pensare di sfruttare la tenuta come azienda agricola.
Note aggiunte: sopra la testa ci volavano aerei rumorosi, che rendevano più forte la sensazione di essere in una altro tempo, in un’altra latitudine. Lo stesso per le automobile che sfrecciavano sul ponte che attraversa la Portuense proprio all’ingresso dell’area. La grande generosità di Emanuele nello spiegare nei dettagli (cosa qui da impossibile da rispecchiare) le vicende, la struttura, le funzioni di questo sito ha di certo contribuito a farci riconoscere il senso della Storia in un momento in cui questo sembra essere annientato…